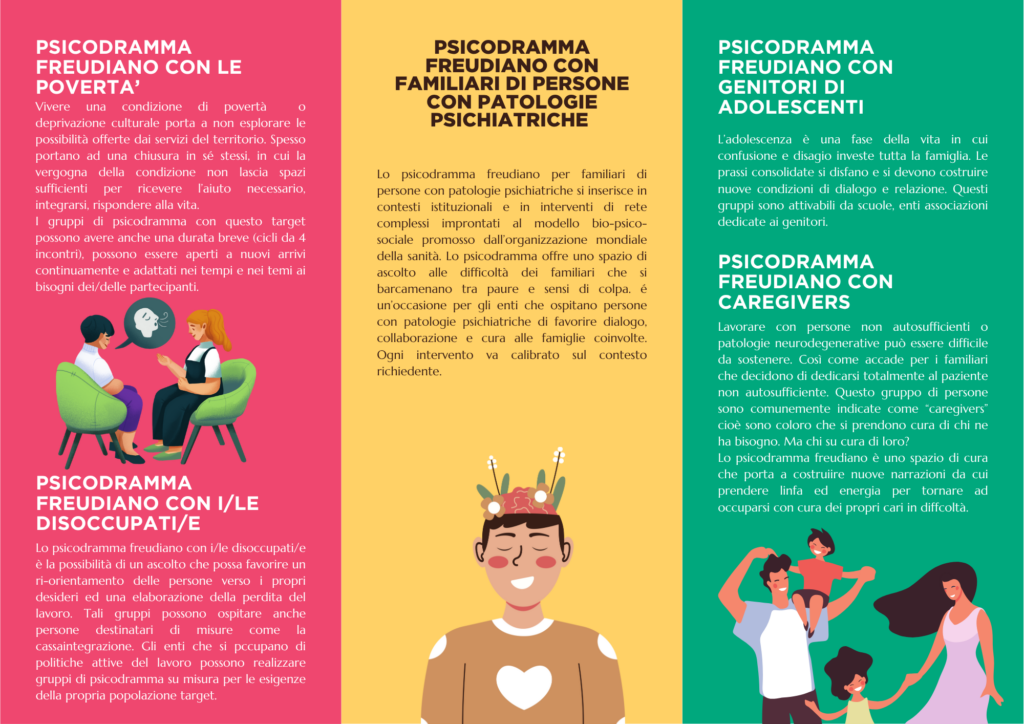
Il mondo della cura oggi deve trovare modalità d’intervento sociale e/o educativo valide, soprattutto quando coinvolge soggetti con ostacoli sociali (ex-tossicodipendenti, famiglie multi-problematiche, caregivers di persone con disabilità, disoccupati). La Compagnia S. Freud ha come scopo quello di sviluppare capacità e conoscenza in una prospettiva personale e civica e vuole sensibilizzare alla salute psichica per tutti. Sostiene lo studio e lo sviluppo dello psicodramma Freudiano e della psicoanalisi applicandoli nella sperimentazione di nuovi interventi con lo scopo di sostenere chi lavora con le marginalità e le persone che vogliono migliorare i loro approcci con essi, creare nuove alleanze e diversificare l’offerta per adulti, internazionalizzare la formazione allo psicodramma.
Le attività promosse dall’associazione hanno come destinatari (learners) insegnanti, operatori sociali, educatori, studiosi, psicologi e psicoterapeuti, assistenti sociali, professionisti dell’aiuto e studenti universitari.
Con il progetto “Inciampi” l’associazione si è aperta a learners appartenenti a gruppi con minori opportunità, ed ha creato dei percorsi ad hoc da svolgere in collaborazione con enti partners.
Tutte le marginalità sono accomunate, a causa di contingenze socio culturali oppure per eventi traumatici a cui sono stati sottoposti, dalla necessità di sviluppare o riparare/ristrutturare alcune competenze per la vita
Dalla riflessione con gli enti sostenitori del progetto, abbiamo capito che una delle sfide maggiori nell’incontro con gli adulti con ostacoli economico-sociali o i loro caregivers, è coinvolgerli in percorsi con finalità specifiche che non siano sostegno al reddito ma esperienze trasformative. Quale offerta per accompagnarli in un cambiamento e favorire una nuova narrazione di sé per integrarsi nuovamente nella società? Per rispondere abbiamo sperimentato dei gruppi di psicodramma freudiano sottoponendoli poi ad una revisione scientifica, in modo da ratificare un modello di intervento che poi possa essere replicato.
Presentiamo di seguito una breve presentazione degli interventi effettuati.
Incontri presso la Caritas Montelabbate
L’esperienza si avvia con la richiesta di collaborazione e sostegno al progetto Erasmus+, l’integrazione degli adulti a rischio di marginalizzazione. Si è pensato di rivolgere l’invito alle sole donne, immigrate proventi dalla Nord Africa, Senegal, Sri Lanka, i cui mariti sono impegnati in fabbrica mentre loro fanno piccoli lavori di assistenza familiare, soffrendo una particolare condizione di solitudine ed emarginazione. Sono stati pensati e realizzati quattro incontri: un primo di presentazione, e tre di discussione.
Ci siamo interrogate, sin dall’avviamento del progetto, se la psicoanalisi ed in particolare il dispositivo dello psicodramma freudiano, potesse rappresentare uno strumento adeguato per poter ascoltare una realtà tanto influenzata dal peso di un Reale così ingombrante. Sin dall’avvio dell’esperienza con il gruppo ci siamo rese conto della difficoltà ad avvicinare le persone che si rivolgevano alla Caritas, delle quasi 50 famiglie, in cui preferibilmente le donne si rivolgevano ai servizi offerti, soltanto 4 si sono presentate all’appuntamento.
La comunicazione all’interno del gruppo non è facile, innanzitutto per le difficoltà linguistiche: sono in Italia da molti anni, ma non parlano italiano con nessuno, sono quasi sempre in casa e quando lavorano stanno in silenzio come, d’altronde, viene chiesto loro.
Chiediamo loro qualcosa della loro storia, dei loro desideri lavorativi, ma ci troviamo davanti alle loro facce perplesse, non sono abituate a pensare cosa desiderare.
Solo nel secondo appuntamento ci hanno potuto dire che parlare di problemi e difficoltà è un argomento “impossibile”, non se ne parla se non in famiglia o si tiene tutto per sé.
Anche lo stesso discorso intorno alle loro condizioni di difficoltà economica e lavorativa incontra paura del giudizio e vergogna, è come se fosse preclusa la possibilità di affrontare la propria presa soggettiva di quanto sta avvenendo nella loro vita, diranno “si va avanti” in una logica di un “accontentarsi” rimanendo fuori dal discorso su di sé.
La cosa che ci ha sorpreso ancora di più è stata la risposta da parte delle istituzioni che sarebbero favorevoli ad una autentica integrazione, ma che hanno difficoltà a pensare progetti con loro, anche se continuano a fare su di loro progetti in cui vengono messe a disposizione risorse “bonus” di vario genere, e pur tuttavia non prevedendo uno spazio per l’ascolto.
Gruppo dis-occupare – occupare
Il gruppo di psicodramma che si è svolto presso la Camera del Lavoro di Firenze, in collaborazione con la categoria Nidil- cgil, ha avuto una cadenza settimanale per un totale di 4 incontri.
L’invito metteva in evidenza la questione del “ri-orientarsi verso i propri desideri, per rientrare nel modo del lavoro con più energie”, e proponeva di fare un “buon uso” del proprio tempo, intendendo con questo che il gruppo poteva essere un “buon uso”. Altri significanti evidenziati dall’invito erano il “futuro” e l’ “elaborazione” del passato. Gli incontri erano gratuiti ed aperti.
Ciascun partecipante ha fatto un leggero movimento. Quello che ho rilevato come interessante è un cambiamento nella visione del “lavoro” e una interrogazione sulla propria posizione in merito alla “ricerca” del lavoro.
Il lavoro è stato descritto inizialmente come oggetto perduto. Tutti hanno raccontato come fosse accaduto e come li ha colti questa “perdita”. L’inatteso di un licenziamento anche se l’azienda non sembrava in sofferenza, il disatteso di un accordo verbale precedente con i datori di lavoro, la delusione di una prospettiva o una promessa non realizzata.
Per Eleonora il gruppo di psicodramma è stata una risposta a questa difficolta, specifica, della ricerca del lavoro, in cui spesso si è soli. Il gruppo offre un posto in un legame diverso che lei mostra di apprezzare molto, interagendo tanto e ascoltando in modo attento. L’interrogativo su cosa desiderasse fare ha preso forma, rivelando una visione idealizzata di sé e di cosa desidera fare.
Il suo discorso ha virato da “sono molto brava nel lavoro che facevo nell’azienda e mi piaceva” ad un’apertura in cui l’ideale di “quella che sa fare le cose e che faceva un lavoro in cui era soddisfatta” cede un pochino il passo ad una messa in questione a partire dall’introduzione di una perdita (passando dall’identificazione nel gruppo dei disoccupati) e da un poter dire la propria confusione su cosa desidera. Arriva alla messa in moto di una ricerca attiva del lavoro, infatti al terzo incontro racconta delle ricerche fatte, dei siti esplorati e dispensa consigli all’altro partecipante, proponendosi di aiutarlo in questo.
Lorenzo mi chiama per iscriversi. Nella telefonata è un fiume: ce l’ha con l’azienda che lo ha licenziato, ce l’ha con la cgil che gli sta “combinando casini” con la disoccupazione, che non difende i diritti. È tanto arrabbiato. “è buono che ci sia la psicologa anche a questi incontri, perché ne ho bisogno in questo momento”, dice.
Si presenta, racconta dei suoi lavori passati, che è stato un lavoratore sempre ligio, che non si meritava questo licenziamento. È in movimento attivo nella ricerca del lavoro: sta mandando curriculum, sta facendo colloqui, si è iscritto ad un corso regionale per prendere la patente da “mulettista”. Il primo gioco che mette in scena è quello di un colloquio. È un colloquio in cui lui si mette in mostra bene, con umiltà e semplicità. Spesso nel gioco, e anche dopo da posto, dice che a lui “basta lavorare”, “qualunque lavoro sia”.
Nell’ultima seduta Lorenzo è furente per aver scoperto di ricevere una NASPI molto più bassa del suo stipendio solito. Propongo a Lorenzo di giocare il momento in cui scopre la cifra della Naspi. Il gioco vede Lorenzo che si arrabbia e ne parla con il figlio che gli risponde: “che vuoi babbo…io lavoro in un bar a nero tutti i giorni per 500 euro…” .
Il gioco fa parlare gli altri membri del gruppo e Ale dice: “Ho visto l’impotenza” rispetto al capo. Il secondo gioco viene da un racconto di Michele: il suo capo lo riprende perché va via dal lavoro 20 minuti prima mentre nei due giorni precedenti era andato via 1 ora dopo il suo turno per completare alcuni lavori e questo non gli era stato riconosciuto. Viene chiamato a giocare Lorenzo che durante il gioco, per un cambio, fa la parte di Michele. Da posto dirà: “io avrei detto qualcosa sui due giorni precedenti” ma nel gioco si vede, per entrambi, l’impossibilità di rispondere al capo. Da posto, Lorenzo recupera nella memoria un ricordo: delle ragazze, nell’azienda in cui lavorava venivano trattate male, pagate male e sono andate via. Dice: “Farei di tutto…ma un lavoraccio no”.
Rimando a tutti che pare che la dignità sia un punto su cui non si è disposti a cedere e che questo, è una buona cosa.
A conclusione della seduta Lorenzo è tranquillo e durante i saluti mi dice “mi scusi, ero molto arrabbiato ieri e anche quando sono arrivato qui. Ma poi mi sono tranquillizzato. Grazie”.
Gruppo Caregiver e Operatori Domus
È stato avviato un gruppo aperto a caregiver e ad operatori della struttura Domus, una casa di riposo specializzata in servizi di accoglienza di anziani semi e non autosufficienti.
Si presentano 14 partecipanti, quasi la totalità sono operatori (infermieri e OSS) e solo un piccolo gruppo di caregiver (3), tutte donne. Il conduttore presenta il pre-testo: l’inciampo. Così iniziano le associazioni da parte di ogni partecipante. L’ostacolo che costringe a fermarsi; il cadere; il rialzarsi. E allora l’interrogativo: come si affronta l’inciampo? È Maria, un’OSS, la prima a riportare la sua di modalità di risposta all’inciampo, e lo fa portando però la sua storia personale, le separazioni, i lutti, il suicidio del fratello.
In associazione alle parole di Maria, parla Chiara che si lega portando anche lei la perdita del fratello: “a volte basta una parola dell’altro per sentirsi accolti, ascoltati, non più soli”. È questo il sentimento che Chiara ha sperimentato nel portare sua madre proprio in questa struttura, combattuta tra il senso di colpa e la paura di abbandonarla e la necessità di trovare un luogo sicuro di cura. Proprio questo conflitto interiore porta ad un’altra associazione, quella relativa ad uno scambio/scontro avvenuto proprio tra Chiara e sua madre, in cui Chiara riferisce, per la prima volta nella sua vita, di aver urlato a squarciagola contro una madre da sempre dominante e controllante, riversando su di lei tutta la rabbia e la frustrazione accumulata da anni, e una madre che rimane muta, senza una parola di consolazione, dimostrando quanto si inciampi in cordoni ancora difficili da tagliare.
Si propone di mettere in scena questo ricordo: Chiara sceglie proprio Maria per rappresentare sua madre ma, nel gioco, Chiara nel suo posto rimane ammutolita, gelata, bloccata, mentre Maria nel cambio di ruolo si dà parola, urla, con sue parole, contro questa madre, inconsciamente forse pensando alla propria.
Ma allora che farsene di questa rabbia, come riuscire a superarla? Tendendo la mano all’altro, con-dividere con l’altro, ma anche lasciandosi accompagnare dall’altro, come il racconto di un’altra infermiera suggerisce, la quale riporterà poi il suo “primo passo” in questa struttura, in questo lavoro così complesso.
Gruppo genitori – Manmamma
Il gruppo nasce dal desiderio di lavorare con l’adolescenza a vario titolo, per tale lavoro si è scelta un’associazione sul territorio che si occupa di minori, ragazzi e famiglie, un contenitore con l’intento di accogliere genitori di ragazzi adolescenti che si trovano ad affrontare questa complessa fase, che a volte non trova “spazi di parola” utili a dare un posto anche all’emotività delle famiglie e agli “inciampi” che si incontrano.
Il gruppo di genitori vede la partecipazione di 7 persone, tutte donne, madri di adolescenti e bambini che, a partire dall’inciampo come pre-testo, iniziano ad interrogarsi sulla difficoltà di comprendere i propri figli in adolescenza, quando la comunicazione inciampa e le distanze si allungano. “Una madre – dice qualcuno – riesce sempre a scorgere i segnali che un figlio comunica, al di là delle parole; e per una madre i figli devono rispondere, aderire completamente alle sue richieste”. Come per una partecipante, una madre di tre figli, che porta un momento con suo figlio Diego, il primogenito, il più grande, al quale delega, spesso, la responsabilità di badare ai due più piccoli; la madre chiede sostegno al figlio più grande il quale però si autorizza a rispondere: “Badali tu i bambini, sei tu la madre!”. È attraverso la messa in scena nel gioco psicodrammatico di questo momento che la madre, nel cambio di ruolo, può cogliere il punto di vista di Diego, riconoscendo che, nella parte del figlio, chiede anche lui di essere visto in quanto bambino, di riservargli uno spazio privato, con uno sguardo privilegiato, unico, solo su di lui; “sono anche io un bambino” sembra dire Diego a sua madre.
Incontri rivolti ai caregiver familiari degli ospiti della Residenza Sanitaria Psichiatrica “Le Radici” e il Gruppo Appartamento “La siepe”.
È stata inviata a tutti i familiari degli ospiti una lettera di invito a partecipare a due incontri di psicodramma freudiano, al fine di creare uno spazio per fermarsi a ripensare e riflettere sugli inciampi che ciascun caregiver può incontrare nel fronteggiare la malattia del proprio familiare.
Per facilitare la presa di parola e la messa al lavoro si è pensato di proporre per ciascun incontro un tema. Gli argomenti proposti sono stati:
Ø il carico di cura, inteso come i livelli di carico percepiti dai familiari a fronte della disorganizzazione sintomatologia, della conflittualità o l’ostilità manifesta in famiglia, dell’ideazione suicidaria, della cronicità della malattia, dello stigma sociale e delle possibili ricadute.
Ø il distacco, ovvero l’insieme dei sentimenti provati dai parenti nel momento del ricovero di un proprio familiare e probabilmente rivissuti successivamente ogni qualvolta deve essere riaccompagnato in struttura dopo un’uscita in famiglia o una breve permanenza a casa.
Nel primo incontro emerge l’urgenza di raccontare la condizione della malattia mentale dei propri familiari, senza inizialmente riuscire ad entrare nel proprio vissuto soggettivo. Tuttavia, un po’ alla volta il dispositivo ha facilitato la messa al lavoro, spostando il discorso su un piano più soggettivo e facendo emergere argomenti sensibili tra cui: il non sentirsi mai pronti o adeguati, il senso di colpa, la preoccupazione riguardo al “quando non ci sarò più”, la paura per i loro comportamenti, la pericolosità, il non sapere circa le origini della malattia, il salvarli così come il salvarsi, l’ambivalenza amore/odio, l’impotenza, l’imprevedibilità.
Nel secondo incontro si fa un gioco in cui M. parla dell’inciampo di una telefonata ricevuta di notte dalla Tailandia dove il figlio era stato fermato in aeroporto perché stava cercando di portare una katana; M. sceglie A. per fare la parte del figlio. Nel commento M. dirà di essersi sentita a disagio nella sua parte e, al momento dello scambio di posto, di “essersi sentita come lui: gli stupidi sono sempre gli altri”. V. interviene dicendo che anche lui ha ricevuto una telefonata in cui la figlia pretendeva che lui la andasse a prendere in tarda sera perché non aveva voglia di aspettare il treno successivo a quello che aveva perso. Nel gioco che segue viene fatto un cambio di posto e alla conclusione, quando viene riportato a parlare dal suo stesso posto, V. fa un lapsus e continua invece a parlare facendo ancora la parte della figlia. L’osservatore commenterà che l’errore di V. ci dice che è comodo stare nel posto dell’altro ed è più difficile stare nel posto del genitore, del bravo genitore, questo discorso si ricollega alla sessione precedente ed alla questione del senso di colpa con cui M. aveva aperto. Ecco che si vede come l’ultimo gioco della seconda sessione risponde alla questione che M. aveva sollevato nel suo prendere per prima la parola nella prima sessione.
I terapeuti si sono mossi col desiderio di accogliere la domanda di un’utenza che spesso non trova uno spazio di ascolto sufficiente, ma che presenta evidenti domande e criticità. In questo ambito lo psicodramma ha favorito il confronto e la messa al lavoro a partire dal contributo che ciascuno partecipante ha potuto offrire, esponendo i propri “inciampi”. Questi hanno trovato ascolto e sono stati accolti e lavorati dal gruppo attraverso i giochi, consentendo a ciascun partecipante di cogliere l’occasione di riflettere sul beneficio che hanno tratto dal prossimo.